Stammati Sergio
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ FRA PASSATO E PRESENTE - THE SUBSIDIARITY PRINCIPLE BETWEEN PAST AND PRESENT
in Diritto e società, 2011, fasc. 2-3 pag. 337 - 427
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
[Abstract tratto dalla rivista]
In the first part the paper shows the evolution of the subsidiarity principle during the liberal and the authoritarian time of Italian history, including, during both periods, the strong positions contained in the popes encyclicals, full of recalls to the French culture at the end of the 19th century and to the German culture during the first part of the 20th century. The encyclicals therefore hold a centralistic position to match with the social sterility of the liberal state, but also a more liberal position in order to control the intrusiveness of the Authoritarian State. In the middle part the paper analyses the German constitutional experience (it also lingers shortly on the Austrian one) from the Weimar period to Hider's period, especially the intellectual experience of the so called ordo liberals in the second part of thirties, because of the significant role that the principle played in both experiences, that stands out after the end World War II, especially in the social economy directed by the Minister of Economy and later Chancellor Ludwig Erhard. Before discussing the late discussion on the subsidiarity principle in Italian legislation, the work analyses shortly the European debate caused by the inclusion of the subsidiarity principle first in the "Atto Unico Europeo" and then in the Treaty of Maastricht. The late birth of a debate in Italian legislation on the principle is illustrated, tracing the most important points of view that have preceded the 1999 - 2001 constitutional reform and also, after the reform, the constitutional case law, weakly supported by the legislator in application of the reform, in search of a better definition of the different responsibilities between legislative and administrative powers of State and Regions. According to the A. the general constitutional project did not succeed in reaching the strong application to which it aspired, regarding the repartition of legislative and administrative responsibilities, dominated by a strong contrast between filo regionalistic and filo autonomistic tendencies. For opposite reasons, exposed in the text, the subsidiarity principle did not succeed in having a significant role, either in the legislative field in which centralistic courses have prevailed in the constitutional case law. Where the mechanism of the attraction in subsidiarity, also centralistic, occupied a narrow role, nor in the administrative field because of the frailness of the smaller autonomistic institutions on which the principle ought to find its base. In the final part the paper critically discusses opposite thesis relative to the horizontal form of the subsidiarity principle, some much too skeptical, others much too enthusiastic. Even if the A. agrees with the thesis of immediate applicability of art. 118, IV paragraph of it. const., he considers that necessary distinctions have to be traced with the aim of avoiding too late and baseless applications of the principle.[Abstract appeared in the Journal]
Sommario: A) La struttura logica: le forme. - A.1. Lo schema logico applicabile alla sussidiarietà verticale. - A.2. Gli schemi logici applicabili alla sussidiarietà orizzontale. - A.2.1. La prima variante del principio di sussidiarietà orizzontale. - A.2.2. La seconda variante del principio di sussidiarietà orizzontale. - B) I precursori. - C) La vicenda storica del principio di sussidiarietà a partire dalla nascita dello Stato di diritto nell'Europa continentale. Breve sintesi. - a) L'ottocento. - b) Il principio di sussidiarietà nel periodo fra le due guerre mondiali. - b.1. Il principio di sussidiarietà nella Carta del lavoro. La concezione eteronomo-autoritaria del principio. - b.2. Il principio di sussidiarietà nell'enciclica "Quadragesimo anno". La concezione personalistica, e autonomistico-corporativa del principio. - b.3. Questioni dibattute nel rapporto fra concezione cattolica e concezione autoritaria della sussidiarietà. In particolare la riflessione di A. Merkl. - b.4. Il principio di sussidiarietà al tempo della Costituzione di Weimar. Cenni. - b.5. Il principio di sussidiarietà alla base delle teorie ordoliberali. - c) Il principio di sussidiarietà nel dibattito del II dopoguerra. - c.1) Il dibattito iniziale. - c.1.1. In Italia. - c.2) In Germania. - c.2.1. Il ruolo storico del principio. - c.2.2. Principali svolgimenti del dibattito costituzionale tedesco sul principio di sussidiarietà. Cenni sintetici. - D) L'emersione del principio di sussidiarietà nell'ordinamento della Comunità europea. - D.1. Le circostanze. - D.2. L'ambigua formulazione positiva del principio e l'indeterminabilità dei suoi possibili riflessi. - D.3. La procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà. - D.4. La nascita e l'allargamento scientifico della comunità degli interpreti dei Trattati. Ovvero il dibattito costituzionale europeo sul principio di sussidiarietà e sulle sue più significative implicazioni. - D.4.1. Il dibattito sulla natura del principio. - D.4.2. Il dibattito sulle competenze e sulla loro distribuzione fra Comunità e Stati membri. - D.4.3. Il dibattito sulla democrazia nell'Unione e sulle implicazioni istituzionali del principio. - E. La vicenda italiana del principio di sussidiarietà. - E.1. Osservazioni generali e di metodo. - E.2. Su alcune letture generali del principio di sussidiarietà antecedenti alla sua costituzionalizzazione. - E.3. I primi riflessi positivi del principio comunitario della sussidiarietà sulla sussidiarietà verticale e su quella orizzontale. - E.3.1. Il principio di sussidiarietà nella legislazione amministrativa anteriore alla Costituzione. Cenni. - E.4. Il principio di sussidiarietà nella Costituzione. - E.4.1. Aspetti generali e indiretti della presenza del principio di sussidiarietà nel T. V, II parte, della costituzione e cenni all'influenza del principio sul rapporto fra le fonti di ordinamenti giuridici, separati e collegati. - E.4.1.1. Aspetti generali. - E.4.1.2. Sussidiarietà e fonti del diritto. Il principio di sussidiarietà come principio regolato e come principio regolatore. Cenni. - E.4.2. L'influenza del principio di sussidiarietà sulla distribuzione costituzionale del potere legislativo fra lo Stato e le Regioni secondo la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 117 Cost. - E.4.3. Se la determinazione dell'ampiezza dei tre tipi di potere legislativo nell'articolo 117, II, III e IV comma, Cost. e la distribuzione del potere legislativo fra Stato e regioni siano dovute all'influsso del principio di sussidiarietà. - E.4.4. Il principio di sussidiarietà nei primi tre commi dell'art. 118 della Costituzione. - E.4.5. Il principio di sussidiarietà nell'art. 118, IV comma della Costituzione. - E.4.6. Alcune letture della formula costituzionale dell'art. 118, IV comma, Cost., sul principio di sussidiarietà orizzontale. - F. Sussidiarietà e diritti. - G. Qualche osservazione conclusiva.
Fonti
- C. Cost. 1 ottobre 2003, n. 303
- convenzione Consiglio d'Europa Roma 4 novembre 1950 (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Costituzione art. 114
- Costituzione art. 117
- Costituzione art. 118
- legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
- legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- Tr. UE (Lisbona - 2009) art. 5
 Versione PDF
Versione PDF
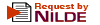 Document delivery
Document delivery